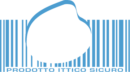Il Pesce : Marano Lagunare e la sua cucina
Il Pesce nr. 4, 2019Rubrica: Storia e culturaArticolo di Orel G. , Pellizzato M. , Zentilin A. (Articolo di pagina 132)
“Na teciada de cape”
Se oggi è largamente diffuso il consumo di bivalvi anche nel periodo estivo, si deve comunque ricordare che nella tradizione di Marano Lagunare (UD) e di molte altre comunità pescherecce dell’Adriatico era fortemente sconsigliato mangiare questi frutti di mare. Non molto tempo fa, diciamo una cinquantina di anni, nessuno a Marano Lagunare consumava bivalvi (cape) nel periodo estivo, perché il consumo di questi molluschi era percepito come molto rischioso, in quanto poteva provocare problemi alla salute anche gravi: dai semplici disturbi intestinali a vere e proprie malattie che, per le persone debilitate, potevano portare alla morte. Peoci (mitili), cape tonde (cuori di laguna) e ostriche (ostriche piatte) erano fra le specie ritenute più pericolose da mangiare in estate, mentre le capelonghe (cannolicchi) non erano disponibili poiché la pesca di mestiere, ieri come oggi, veniva esercitata solo nel periodo da ottobre a marzo.
Una volta le cape erano considerate il cibo dei poveri in quanto erano molto abbondanti, facili da raccogliere e disponibili sia in laguna che nel litorale con una buona varietà di specie; in cucina, poi, non richiedevano l’uso di grandi fuochi, ma erano facilmente de¬pe-ribili e non adatte al trasporto per l’assenza di frigoriferi e ghiaccio. La cattiva nomea di cui godevano questi molluschi filtratori derivava da un insieme di caratteristiche peculiari e all’impreciso stato delle conoscenze e dell’igiene che fino a qualche decen¬nio fa prevaleva in larga parte del nostro Paese. Lo sversamento di acque spesso contaminate da batteri fecali nei fiumi, in laguna e in mare, la presenza dei banchi naturali in vicinanza degli scarichi, il libero accesso alla risorsa, la facilità con cui potevano essere raccolti e la scarsa conoscenza delle dinamiche di prevenzione sanitaria, permetteva¬no scambi, contaminazioni frequenti e veloci fra gli organismi patogeni, l’alimento molluschi e le popolazioni rivierasche. Questo dualismo tra facile disponibilità di risorse a basso costo e la loro potenziale pericolosità è una caratteristica presente in tutte le comunità costiere del pianeta. Oggi, con le aumentate conoscenze scientifiche, le cose sono molto migliorate: le normative e i controlli sono giustamente molto severi, a tutela della salute, e anche noi possiamo fare qualcosa quando acquistiamo i molluschi da preparare a casa senza incorrere nei rischi capitati ai nostri avi. Innanzitutto leggiamo le indicazioni contenute nell’etichetta, che ci dicono:
- quale specie stiamo acquistando;
- come viene prodotta, allevata o pescata;
- da dove viene;
- che il prodotto deve essere vivo e vitale al momento dell’acquisto, il che sta ad indicare che, se uno tocca con le dita un mollusco con le valve aperte, questo si deve chiudere;
- che il prodotto va tenuto ad una temperatura compresa tra 0 °C e +6 °C;
- che il prodotto va consumato cotto, poiché con la cottura vengono “uccisi” gli eventuali agenti patogeni, possibili cause di infezioni gastroenteriche. Si ricorda che i molluschi sono da considerarsi “cotti” quando, dalla loro apertura nel tegame, la cottura prosegue per altri 5 minuti.
L’etichetta ricopre un ruolo fondamentale, tanto che la si può definire la “carta d’identità” del prodotto a cui è attaccata. Merita ricordare, inoltre, che è vietato dalle norme acquistare bivalvi direttamente dalle imbarcazioni. Se nelle pescherie questi molluschi sono immersi in recipienti con acqua o se vengono “bagnati”, le cape perdono le caratteristiche di garanzia con cui sono usciti dal Centro di Spedizione, e quindi non sono da acquistare.
Prima delle etichette
Ritornando alla nostra storia, diciamo che le specie di molluschi bivalvi utilizzate nell’ambito costiero del Nord Adriatico ai fini alimentari e anche come “cibo di strada” erano molto più varie di quelle impiegate oggi. I nostri vecchi conoscevano perfettamente tutte le specie commestibili e le loro qualità organolettiche; di conseguenza usavano anche modi originali per prepararle.
Ai nostri giorni, chi sa distinguere con sicurezza un’ostrica piatta nostrana (Ostrea edulis) da un’ostrica concava “portoghese” (Crassostrea gigas), ormai naturalizzata? Un longone (Tapes aureus) da un lupino (Chamelea gallina)?
Una vongola verace autoctona (Tapes decussatus) da una vongola verace filippina (Ruditapes philippinarum), ora definitivamente adattata nelle lagune alto-adriatiche? Una capa de deo (Ensis minor) da una capa de fero (Solen marginatus) o dal cannolicchio oceanico (Ensis directus) proveniente dall’Olanda, oggi sempre più presente nei nostri ristoranti perché disponibile tutto l’anno?
Chi sa distinguere una cozza pelosa o modiola (Modiolus barbatus), un mitilo o cozza atlantica (Mytilus edulis) e un mitilo mediterraneo (Mytilus galloprovincialis)? La capasanta atlantica (Pecten maximus) dalla quella adriatica (Pecten jacobaeus)?
Chi riconosce le tre specie di canestrello (bianco, rosso e nero)? Chi sa riconoscere le due specie principali di telline, le cape a forma di scure (Donax semistriatus e Donax trunculus) presenti da noi?
Chi tra i giovani sa cos’è el caparossolo dal scorso fin (Scrobicularia plana), ormai quasi scomparso dalle lagune ma ancora presente nei ricordi dei nostri vecchi che lo declamano per gusto e delicatezza delle carni definendolo el re de le cape?
Memorie di cucina
Tra i ricordi di cucina, tralasciando gli attuali spaghetti ai frutti di mare, la saltata o l’impepata di cape, oppure i “soliti” gratinati caldi, ci sovviene cosa invece ci raccontava zia Lisetta, di come i Maranesi, a fine della giornata di pesca, solevano riunirsi in osteria per gustare le cape tonde (Cerastoderma glaucum), semplicemente “scottate” in uno scolapasta dove veniva versata sopra dell’acqua bollente ma poi, per mangiarle, bisognava aprirle “sciavetandole, cul con cul”! (NdR: per riuscire a separare le due valve, si prendeva tra pollice e indice di ogni mano un cerastoderma, poi si ponevano in contatto le due parti imbonali incernierate e, premendole con forza una contro l’altra, si esercitava una rotazione fino a che le cerniere non cedevano, schiudendo le due valve).
Infine, avete presente i mussoli (Arca noae) tuttora pescati in minime quantità sui fondi fangosi detritici della costa istriana, nel Quarnero, tra le isole dalmate e al largo di Lignano, tra le concrezioni dure (grebeni) conosciute un tempo come mussolera? Fino alla metà degli anni ‘70, in diversi rioni di Trieste (San Giovanni, San Giacomo, Cavana, ma anche a Muggia), generalmente in vicinanza di osterie, facevano bella mostra di sé i banchetti de mussoli. Si trattava di semplici carretti attrezzati con un fuoco e una larga padella su cui, in un unico strato coperto da uno straccio bagnato, venivano cotti i mussoli, ma non troppo, per evitare che le carni divenissero coriacee. Quello che nel tempo non è cambiato è accompagnare le nostre cape con i nostri vini: la Malvasia istriana e il Tocai, scusate il refuso: il Friulano!
Giuliano Orel
Michele Pellizzato
Aurelio Zentilin